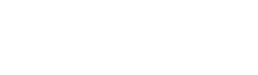di Annapaola Voto

La libertà è un ambiente in cui si possono cogliere delle opportunità e si riconoscono i diritti. Non è affatto scontato, non lo è mai, non lo è oggi, un oggi insidiato da molti rischi. La mia vita professionale è nata e cresciuta all’interno della Pubblica amministrazione. Quando ho pensato, con tutti i miei collaboratori, di “mettere in ordine” le molte azioni che, da quando dirigo IFEL Campania, abbiamo svolto per rafforzare, promuovere, incentivare le azioni pubbliche a favore della parità di genere, ho pensato che riflettere sul cammino delle donne nella PA potesse essere interessante. Perché questo cammino ci restituisce, paradossalmente, pur nella marginalizzazione dai ruoli di vertice, una storia appassionante di competenze tecniche e dedizione produttiva. Un confronto con la società contemporanea può essere illuminante. In questo speciale, dunque, accanto a una sintesi essenziale delle cose che abbiamo messo in campo e nuovi spunti argomentativi, spero possiate trovare una chiave per comprendere l’urgenza delle sfide future. E anche un omaggio a una parte importante della nostra storia repubblicana.
“Il perfetto vademecum della signorina impiegata è quello di assentarsi saltuariamente, di tanto in tanto, per alcuni giorni, nessuno dei quali, beninteso, cade di domenica; e durante le ore di ufficio le operose attendono alla fabbricazione di fiori, e quelle a tendenza sentimentale a lettura intensiva dei romanzi di Guido da Verona od altri simili, con gite collettive per i corridoi, a chiacchierare con speciale considerazione dei fattacci del giorno”.
Questo passaggio è tratto dagli Atti parlamentari, seduta della Camera del 25 febbraio 1921. Lo pronunciò Felice Bertolino, deputato piemontese, nel corso di una discussione sulla istituzione di quella che sarebbe poi stata la commissione di inchiesta Giolitti sulla pubblica amministrazione.
Due anni prima una legge ritenuta rivoluzionaria sulla capacità giuridica delle donne voluta da Ludovico Mortara ammetteva le donne a a esercitare “a pari titolo degli uomini” tutte le professioni, e a coprire “tutti i pubblici impieghi”, esclusi quelli – diceva la legge – che implicassero “poteri pubblici giurisdizionali, o l’esercizio di diritti o potestà politiche, o che (…) attenessero alla difesa militare dello Stato”.
La Pubblica amministrazione era decisamente respingente nei confronti delle donne ma la Grande guerra aveva reclutato i giovani e così negli uffici ci fu bisogno di donne che vennero immesse in massa e senza concorso. Quando rientrarono i titolari dal fronte reclamarono ovviamente i vecchi ruoli, intanto le donne avevano iniziato a lavorare e così furono lasciate ai loro posti, ma come seconda mano, seconda scelta. Iniziava, in buona sostanza, l’epoca del precariato femminile. Prima della guerra le donne, nell’amministrazione pubblica italiana, quasi non esistevano. Facevano eccezione i telegrafi (Matilde Serao aveva scritto persino un romanzo, Telegrafi di Stato: Romanzo per le Signore, 1895, nel quale aveva descritto il mondo al femminile di un grande ufficio telegrafico di Napoli, e i ritmi febbrili della sala macchine sotto la severa custodia di un dirigente maschio, e i patemi e le sofferenze delle ragazze. E i loro amori, le loro speranze, le miserie della loro vita privata anche). Le donne in quel ruolo erano brave, molto brave. Se guardiamo ai processi storici alla luce di quello che oggi viviamo è interessante constatare come le donne, le telegrafiste dell’epoca, avevano competenze innovative di gran lunga superiori a quelle dei loro coetanei maschi. La stessa parità, se confrontata con le competenze digitali del nostro tempo, oggi non c’è. Anzi, come rilevano tutti gli indici statistici (anche quelli che riassumiamo in questo speciale) il gap di genere sulle competenze digitali è preoccupante.
Dove si sono perse le donne?
Di certo non è mai stato facile. Una legge dello Stato del 1909 (n. 528) vietava fino ai 28 anni alle addette agli apparati di commutazione telefoniche (le centraliniste) di sposarsi per non compromettere le loro prestazioni lavorative. (Cosa vi ricorda? Quante storie di dimissioni in bianco da presentare in caso di gravidanza abbiamo letto nei decenni passati?). Venne il fascismo, e se possibile la donna dovette fare un ulteriore passo indietro. Molte norme interne alle singole amministrazioni posero, in ragione del sesso, limiti e sbarramenti al conseguimento in carriera di posizioni di vertice. Fu un crescendo di limitazioni culminato nel decreto del 1938 che disciplinò l’assunzione femminile negli impieghi di Stato, fissando in un massimo del 10% i posti eventualmente disponibili per le donne.
Si riempirono di donne i saloni di lavoro dell’Istat, ad esempio, nei quali le schede (le prime schede perforate) erano lavorate da solerti mani femminili, spesso di giovanissime. E così quelli dell’Ina, dell’Inps. Caduto il fascismo venne la democrazia. Non per i diritti delle donne, però. Fu del gennaio 1951 la protesta delle impiegate dei Monopoli di Stato per le limitazioni ancora vigenti come nel periodo fascista. Altre contestazioni seguirono negli anni successivi. Bisognò attendere il 18 gennaio 1980 perché il Consiglio dei ministri nominasse (superando la famosa barriera gerarchica) due donne dirigenti dello Stato: la dottoressa De Corné al Commercio estero e la dottoressa Forcignanò Brossi al Tesoro. Frattanto, nel 1974, tra Stato, enti locali e enti pubblici, le donne erano diventate circa il 44% degli occupati, il 38% (dato 1975) dei dipendenti ministeriali (nel 1950 non superavano il 20%). Le donne dirigenti (non le dirigenti generali però) erano in tutti i ministeri 188: 142 dirigenti e 46 dirigenti superiori, nessun dirigente generale, nessun prefetto, nessun ambasciatore (gli uomini dirigenti erano 5361, i dirigenti generali 352).
Nel 1983, su 7090 dirigenti nei ruoli dello Stato, le donne furono 455; nel 1984 458 su 7005; nel 1985 525 su 7413. Ma solo 4 sui 795 dirigenti generali o assimilati. Nel gennaio 1989 le donne dirigenti salirono 604 su 7101. E quando nel 1993 Sabino Cassese presentò il suo famoso Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni su tutti i comparti (comprese scuola e università) le donne raggiungevano ormai il 50%, con larga presenza nella sanità e istruzione). Alla fine degli anni ’90 le donne nel complesso del settore pubblico erano 1 milione e 700 mila. Insomma, il passato è alle spalle, ormai, ma la strada da percorrere è ancora lunga.